di Martina Draft
editing a cura di Laura Calagna Bambini
Illustrazione: immagine realizzata con IA generativa
“In questa casa, ogni cosa ti parla.
Ma ciò che dice… dipende da come guardi.”
[La Belle et la Bête – Jean Cocteau]
Alla casa di via Togliatti numero 11 non piaceva quasi niente. Non le piacevano i testimoni di Geova né i venditori porta a porta, che si presentavano senza invito, con supponenza; non le piacevano i pittori edili, che la guardavano con rimprovero. Figuriamoci se le piacevano i sacerdoti, che una volta l’anno passavano a gettare emulsioni di acqua santa sulle facciate. Detestava il traffico di via Togliatti, specialmente a inizio settembre, quando le scuole aprivano lo sfintere, evacuando frotte di bambini che passavano strisciando le cartelle sui muri; per non parlare dei loro genitori, che correvano avanti e indietro con le macchine dai motori indemoniati.
Invece apprezzava i corrieri dei ristoranti, i postini, i runner di Amazon, e tutta la brava gente che con la loro fulminea apparizione mi liberava dall’obbligo di uscire.
La vita all’interno era serena, perché coi mobili la casa andava d’accordo, e i suppellettili la solleticavano. Andava fiera soprattutto di quel quadro un tantino kitsch con scritto “Casa dolce casa”, regalo della genitrice, che mi era toccato appendere in salotto, e che alla fine di questa storia sono rimasta l’unica ad ammirare.
Tutto era iniziato con la pandemia di Covid del 2020, quando il mio datore di lavoro – un ipocondriaco certificato – aveva gentilmente invitato i dipendenti a non farsi più vedere in sede. Non era necessario essere dotati di chissà quale spirito di osservazione per comprendere che dei trentadue impiegati della Zoloft Hi-Tech, radunati attorno all’altare virtuale di Zoom Meeting, nemmeno uno avrebbe sentito la mancanza della canonica vita d’ufficio. Dopo che il capo aveva dichiarato l’inizio della nuova modalità impiegatizia con un sonoro: “Fino a data da destinarsi”, si era sentito il rumore di una bottiglia stappata con enfasi. Solo quando avevo chiuso il laptop e mi ero avvicinata al frigo avevo notato che una delle mie bottiglie di Prosecco era aperta. Avevo maledetto l’eccesso di Co2 dei vini a buon mercato e avevo rimpiazzato il tappo con generosi giri di cellophane. L’indomani, una delle pareti della cucina grondava dello stesso Prosecco che avevo archiviato come esageratamente gasato il giorno prima. Sarebbe stato proprio buffo se, di punto in bianco, la casa si fosse messa a tracannare vino per festeggiare il mio debutto nello smart working.
Il secondo evento bizzarro si era manifestato qualche giorno dopo, quando un’emicrania fortissima mi aveva tolto le forze; avevo preso un giorno di malattia e mi ero preparata una caraffa di camomilla. Niente di nuovo per me, soffrivo di mal di testa dall’adolescenza e il rituale lenitivo era sempre lo stesso: dormita lunga, bevanda calda, minestrina con abbondante formaggio Grana, passeggiata all’aria aperta. Quel giorno invece c’era stato un cambio di copione, a cui avevo aderito senza accorgermene. Innanzitutto, la camomilla sembrava una spremuta di Valium, tanto mi sentivo rilassata; poi ci si è messa la minestrina, che non finiva mai, e che mi aveva fatto raggiungere un soporifero picco glicemico postprandiale. Mi ero data due ceffoni per guancia e mi ero costretta a vestirmi. Ormai pronta per uscire con una tuta in acetato marrone e rosa – che non solo non sapevo di avere, ma che mi faceva sembrare un enorme macaco – mi sono resa conto di non trovare le chiavi. Le avevo cercate ovunque, e alla fine avevo rinunciato. Il fatto che stessi per uscire in ciabatte anziché con le scarpe da ginnastica, mi aveva convinta che era meglio battere in ritirata. Avevo raggiunto il letto in uno stato di felice sonnambulismo, e avevo chiuso gli occhi pensando che le coperte non erano mai state così calde, lisce e accoglienti. I giorni successivi li ho vissuti come in un viaggio lisergico, dove l’emicrania era solo un ricordo ma tale era il benessere della nullafacenza, che non c’era altro da fare che cedervi. Tra sonno e veglia sentivo una nenia rilassante salire dai pavimenti fino ai soffitti, e mi addormentavo paciosa e sorridente, aggrappata ai cuscini.
Una mattina particolarmente vivace, di sole e di luce, avevo ricevuto una chiamata dal capo, preoccupato per il mio stato di salute. Volevo dire che stavo alla grande, ma avevo preferito optare per un giro di parole che lasciasse aperta la possibilità di una ricaduta.
«Ti vedo proprio in gran forma. Ma fai riparare sto campanello che ci ho appoggiato il dito appena appena e mi sono presa una scossa tremenda,» aveva detto mia mamma, due settimane dopo, dalla cornice della porta. Portava un mazzo di fiori ed ero piuttosto contenta di vederla. Probabilmente lo era anche lei, ma indossava la mascherina Ffp3 e gli occhiali, quindi non potevo verificare. Si era accomodata in salotto, avevo preparato un drink e le avevo consigliato di togliersi la mascherina per berlo.
«La tengo. C’è una puzza qui dentro. Dammi una cannuccia.» Strano, molto strano, avevo detto; sentivo solo il profumo dei suoi fiori, ed era squisito.
«No no. Ti dico che c’è puzza, come di cadavere». E si era messa a frugare nell’armadietto dei cestini – vuoti, immacolati – e sotto il lavabo – bello lindo e coi prodotti allineati. Non contenta era andata in bagno, dove ci si poteva specchiare anche sulle mattonelle. Allora si era fermata, braccia intrecciate sul petto, e aveva chiesto:
«Ma te da quand’è che sei diventata così ordinata?»
In realtà, io proprio non lo so. L’ordine era sempre stato un concetto astratto, qualcosa di cui si occupa chi ha delle fisime, o chi passa molto tempo a casa.
Come se mi avesse letto nel pensiero: «Da quant’è che non esci?»
Nemmeno per questo avevo una risposta, ma tanto lei non l’avrebbe aspettata. Stava già correndo verso l’ingresso, non sopportando più l’odore disgustoso. Ho pensato che fosse diventata pazza, lo erano un po’ tutti dopo la cattività del lockdown.
Le settimane si susseguivano con ritmi lavorativi serrati. L’impressione era che le aziende di tutto il mondo, con la scusa dello smart working, non sapessero più che farsene delle domeniche, e raggiungevano i propri dipendenti per telefono alle ore più impensabili. Io non mi sentivo sotto pressione, anzi provavo gusto nell’essere presa come esempio di fronte ai colleghi in riunione virtuale: “… come Alice, che risponde anche di sabato sera – … come Alice, che consegna i suoi progetti finiti già al mezzogiorno del lunedì – … come Alice, che non si lamenta mai per qualche piccolo straordinario”. E così mi ero guadagnata le antipatie del reparto comunicazione e di tutti gli altri reparti. Non mi importava, a casa stavo benissimo, e non ero mai stata così produttiva. I miei amici, nel frattempo, avevano ripreso a uscire, e se i primi mesi post-pandemia mi telefonavano sempre, davanti ai miei rifiuti avevano diradato gli inviti. Non mi mancava la vita all’aperto, e tramite il web potevo avere comodamente tutto quello che volevo, dai libri al cibo, dai vestiti alle scarpe, anche se in quest’ultimo caso i miei acquisti si focalizzavano su un abbigliamento domestico. In virtù della mia nuova vocazione ascetica, avevo dato inizio a uno shopping sfrenato di oggettistica Ikea: nuovi tappeti, lampadari, stoviglie. Era la casa che me li chiedeva. Mi pareva di sentirla parlare, e aveva il tono rassicurante di una madre, ma meno isterica della mia.
Alla fine era arrivato Marco. E centinaia di chat da un social all’altro. Era una storia perfetta, almeno finché non mi ha chiesto di vederci. “Per conoscerci di persona 🙂 🙂 🙂 ”.
Dagli acquisti online di casalinghi ero passata a quelli di abiti da sera, creme per il corpo, tinte per capelli, e con loro una sfortunata serie di contrattempi. I pacchi mi venivano recapitati dai corrieri, e io o non li sentivo o loro non si prendevano il disturbo di suonare il campanello. A volte vedevo le foto della consegna davanti all’uscio, correvo fuori e il pacco era già sparito, oppure il prodotto era sbagliato o danneggiato e toccava mandarlo indietro. Una volta si era addirittura staccato un pezzo di cornicione ed era caduto in testa al povero fattorino, che era corso all’ospedale con ancora in braccio la busta delle mie scarpe tacco 12. Non ne andava dritta mezza, e più cercavo di rimediare, più ne succedevano. Avevo rimandato l’appuntamento con Marco così tante volte che alla fine mi ero rassegnata a una vita di smodato autoerotismo.
Di contro, la casa di via Togliatti numero 11 era sempre più accomodante, e certe mattine mi svegliavo con il caffè già pronto – grazie, nuove tecnologie elettrodomestiche! – e certe altre, quando ero un po’ giù di corda, le pareti si tingevano di colori pastello per tirarmi su il morale.
Un sabato di maggio, apro la porta convinta di trovarmi di fronte a uno dei ragazzi di Zalando, e vedo Marco, in carne, feromoni e ossa. Avevo dimenticato l’eccitazione dei colpi di fulmine, l’ebbrezza del corteggiamento dal vivo, e avevo dimenticato pure quell’accenno di gastrite che ti prende quando qualcuno ti piace davvero e il tuo corpo ci tiene a ricordartelo. Marco era di una bellezza che, ai tempi di internet, si può definire solo “senza filtri”. Tutto in lui era al proprio posto: il naso piccolo e delicato, quei nasi che si trovano sulle facce degli attori; le labbra umide, i denti bianchi e le gengive rosa, che contribuivano a evidenziare un sorriso che avrebbe reso felice ogni odontoiatra. Le gambe dritte, salde e muscolose avvolte in un paio di jeans da magazine GQ; la camicia blu di lino. E poi c’ero io. Con pantofole ortopediche Scholl, felpona di tre taglie più grande con la faccia di Ih-Ho, l’amico triste di Winnie the Pooh, e un paio di leggings tinta Fassona Piemontese.
Malgrado il mio stato, Marco aveva sorriso: «Da quant’è che non esci?!» e poi mi aveva stretta in un abbraccio. L’avevo fatto entrare. E questa è l’unica cosa di cui mi pento.
Nel momento in cui ha varcato l’ingresso, ho capito che qualcosa era sfuggito al mio controllo. Lui non ha tardato a farlo notare. «È casa tua?» aveva detto perplesso.
Macchie di muffa scendevano penose dagli angoli del soffitto, pezzi di intonaco erano sparsi sui mobili, e la spesa che mi era stata recapitata al mattino perfettamente imbustata, copriva irrancidita il pavimento. Le mosche facevano banchetto e giravano per la cucina come se ne fossero padrone; dalla finestra aperta spuntava il sedere di un colombaccio, che aveva scambiato il mio lavello per un water.
«È meglio se torno un’altra volta,» aveva detto, uscendo veloce come era entrato. Le sue gambe dritte, salde e muscolose si erano allontanate in fretta nella luce del giorno, e lui era scomparso in una nuvola di buone intenzioni.
Come avevo rimesso piede in casa, tutto era tornato lindo e profumato.
Avevo aperto il computer ed ero andata sul negozio online di una ferramenta, avevo cliccato su una corda robusta e una scaletta di un metro, e quando avevo pagato l’acquisto il caminetto aveva sbuffato, i suppellettili avevano fatto un balzo, le pareti avevano tremato, e io in cuor mio sapevo che non avrei mai visto quel pacco arrivare. La mia esistenza sarebbe stata consacrata a quelle quattro mura, almeno fino a che la casa di via Togliatti numero 11 non fosse stata rasa al suolo.
Biografia
Martina Draft, classe 1986. Nata e cresciuta a Padova, vive e vegeta nelle Midlands inglesi. Quando non legge, scrive; quando non scrive, fotografa. È cofondatrice di Rivista A\polide, per cui scrive di spatriamenti. Altri suoi racconti sono comparsi su riviste letterarie italiane, tra cui Topsy Kretts, Spaghetti Writers, STC Edizioni, Enne2, L’Equivoco, Linoleum. È cofondatrice di To Raise, uno spettacolo di letture interpretative che porta in scena autrici venete della narrativa contemporanea.





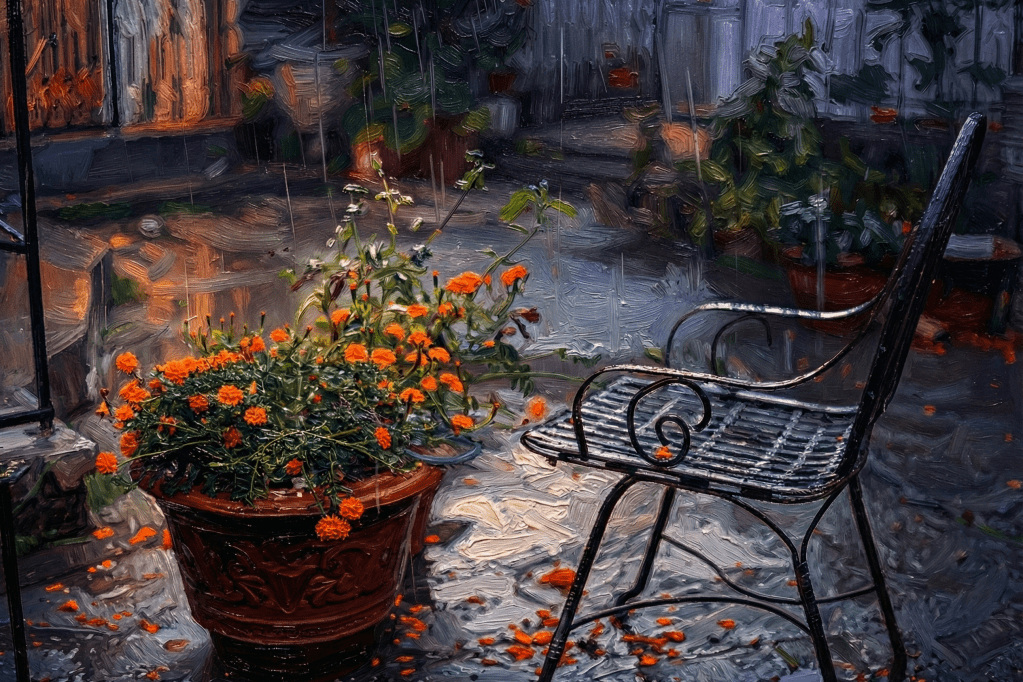
Lascia un commento