di Francesca Barracca
editing a cura di Catherine Hannequart
Illustrazione: immagine realizzata con IA generativa dalla redazione
Il mondo fuori dalla finestra Angelo non lo conosceva. Fin da quando era nato i suoi genitori glielo avevano soltanto raccontato. A chi chiedeva loro perché, rispondevano che là fuori c’erano troppi pericoli per uno come lui. Così raccontavano. A un certo punto, però, le storie erano diventate sempre le stesse e lui aveva smesso di credere che esistesse davvero qualcosa oltre quello spazio assolato.
«E allora le cose che ti diciamo ce le inventiamo?»
«Può darsi.»
«E che bisogno avremmo?»
Angelo si stringeva nelle spalle, fingeva di non sapere che serviva più a loro che a lui. Ogni volta l’inconsistenza delle immagini che descrivevano bruciava sotto le palpebre chiuse con la stessa intensità. Durava pochi istanti, poi tornava tutto come prima. I suoi genitori non si accorgevano di nulla, soprattutto sua madre. Era convinta che i suoi racconti gli facessero bene.
«Dovevi vedere il cielo oggi: era azzurrissimo, come il mare. C’erano un sacco di rondini e un sole che spaccava le pietre!»
Lui scoppiava a ridere. Aveva smesso di chiedere a sua madre che cosa fosse l’azzurro e come potesse il sole spaccare le pietre: l’ultima volta che glielo aveva domandato, a sei anni, lei gli aveva risposto che l’azzurro è azzurro come il cielo e il mare, e che il sole spacca le pietre quando è caldissimo. Angelo le aveva dato della bugiarda: se il sole spacca le pietre, che sono dure, e lui lo sapeva perché le aveva toccate, come poteva non spaccare anche lui quando sostava a lungo sotto i suoi raggi? Così, quando sua madre gli aveva detto che cosa faceva il sole quando è caldo, lui era rimasto alla finestra giorni interi e per interi giorni aveva cercato dei segni di spaccatura sul viso e sulle braccia, ma in cambio sotto le dita aveva sentito soltanto la morbidezza dei peli e la pelle che scottava. Forse era immune al potere spaccante del sole o forse le crepe erano qualcosa che si poteva soltanto vedere. Aveva annusato il braccio, portato la mano alle orecchie, quasi si aspettasse di sentire uno scricchiolio. Ma niente.
«Guarda, mamma, io non mi spacco!»
«Ma così ti bruci, però. Sei tutto rosso! Lo capisci adesso perché non puoi uscire?»
Angelo aveva abbassato la testa in cerca delle bruciature di cui parlava sua madre. Sotto le dita la pelle era calda, ma ancora liscia.
«È perché non riesco a vedere se mi sto bruciando?»
Poi era cresciuto, aveva ascoltato libri, notizie, interviste, documentari, e Verità, questa strana voce robotica che gli descriveva ogni cosa, era diventata la sua migliore amica. Così aveva anche potuto confermare la totale incapacità materna nel raccontargli le cose di là fuori. Si era fatto un’altra idea di realtà che non poteva più corrispondere a quella in cui sua madre l’aveva intrappolato. Se il suo contatto con il mondo esterno fosse dipeso soltanto da lei, Angelo non avrebbe mai potuto sviluppare neanche un briciolo di quella fame di verità che da qualche tempo lo tormentava senza dargli tregua. Di notte sognava le case colorate del porto che Verità gli aveva descritto come a pochi passi da camera sua, le barche attraccate alla banchina e quelle in mezzo all’acqua in attesa del fortunato carico di pescato; sognava di entrare nella libreria della piazzetta e sfogliare i libri esposti, studiare i caratteri delle pagine, perdersi nelle copertine; sognava di confondersi tra i turisti che popolavano le due spiaggette, di piantare lì il proprio ombrellone e bruciarsi – per davvero – al sole; sognava di sentire cantare la sterpazzolina, la balia e la salciaiola e tutte le altre specie di cui l’Osservatorio sulla punta più alta dell’isola si prendeva cura; sognava di visitare le mura del carcere piene di storia e quel che restava della prigione di Giulia, la figlia esiliata dell’imperatore Augusto. Di giorno, invece, passava ore ad aspettare che arrivasse la notte per poter sognare ancora, la voce di Verità sempre guida fedele nella preparazione al viaggio notturno.
Alla finestra non ci stava più, le tendine ormai tirate per schermare tanto il sole estivo quanto la fioca luce invernale. Ora se ne stava a letto a sognare con libri in Braille sulle gambe.
Sua madre e suo padre provavano a tirarlo fuori di lì, ma non ci riuscivano mai.
«Vieni di là? Ti ho portato il gelato!»
«È arrivata la zia Carla. Vuole vederti. Perché non esci almeno a salutarla?»
Poi si passava alle maniere forti. Suo padre sbuffava, spostava i libri e lo tirava su di peso, ignorando i calci che Angelo sferrava all’aria.
Andò avanti per mesi, fino a che la zia Carla non riuscì a strappargli una contrariata discesa dal letto con la promessa di una passeggiata sull’isola. I suoi genitori si allarmarono all’istante, elencando a turno tutte le difficoltà che avrebbe potuto incontrare: scendere un gradino, inciampare in una buca, perdere l’equilibrio, finire sotto un motorino…
«Ci penso io a lui», assicurò la zia.
Angelo era incredulo. Le chiese di giurare. Lei lo fece, ma Angelo non vide che aveva incrociato le dita dietro la schiena.
«Ci vediamo domani mattina alle dieci. Mi raccomando, porta la crema solare.»
L’indomani la zia non venne. Né alle dieci, né alle dieci a mezza, né alle undici, né alle undici e mezza. Angelo aspettò fino alle tre del pomeriggio, poi capì che era inutile: la zia Carla l’aveva preso in giro. Come lei, i suoi genitori e gli insegnanti privati che nel corso degli anni erano entrati in casa per istruirlo su cose che non avrebbe mai potuto vedere.
Tutti non avevano fatto altro che prenderlo in giro da tutta la vita.
Fu allora che conobbe quella sensazione nel petto, di mano che tira pelle e muscoli e costole. Sembrava che volesse strappargli il cuore. Non aveva un nome per definirla, ma si disse che quella forza che lo spingeva verso la porta che dava sull’esterno non poteva essere casuale. Doveva essere assecondata.
Attese l’arrivo della notte per agire con la complicità del buio: muoversi tra i mobili di casa senza urtare niente fu facile come quando lo faceva di giorno, ombra tra le ombre. Più complicato raccogliere il mazzo di chiavi nascosto dietro la pianta all’ingresso e infilare quella giusta nella serratura senza provocare qualche scampanellio. Confidò nel sonno pesante di sua madre e nei tappi che indossava suo padre per non sentire il vociare notturno dei turisti che si attardavano lungo le strade.
Quando fu fuori lo capì dalla profondità. Nel suo raddoppiare, lo spazio aveva incluso anche i rumori più lontani, troppo lontani per essere distinti, troppo presenti per essere ignorati. Si portò le mani alle orecchie e tutto tacque per qualche secondo. Inspirò: l’odore del mare salì alle narici con tale violenza che gli venne da starnutire. Allontanò le mani dalle orecchie con cautela, per abituarsi alle voci dei passanti che si sovrapponevano all’ondeggiare delle barche nell’acqua e al cozzare lontano di bicchieri, piatti, sandali che strisciavano sul lastricato, miagolii, abbai, forse persino squittii. Mosse qualche passo incerto e gli girò la testa. La speranza di scoprire tutte quelle cose che aveva soltanto sognato e che potessero consegnargli una verità nuova, capace di sostituire l’altra, gli fece allungare un altro passo, poi un altro e un altro ancora. A guidarlo era il silenzio che percepiva più lontano da lì, forse oltre il porto, in quella natura incontaminata di cui Verità e qualche volta anche i suoi genitori gli avevano parlato.
A un certo punto credette di esserci arrivato. Non era forse erba alta quella che gli toccava le caviglie? E quel ronzio nelle orecchie? Certo, non era la sterpazzolina e nemmeno la salciaiola, però forse c’era vicino! Avanzò ancora un po’, quanto non avrebbe saputo dirlo, ma gli bastò quell’ultimo passo per inciampare e qualcosa, al brusco contatto, miagolò. Come? Come era possibi–
«Attento!», urlò qualcuno.
Alla voce femminile che veniva da troppo vicino si accompagnò una salda presa sulle spalle e solo quando il rumore di cosa che cade in acqua raggiunse le sue orecchie scoprì di essere scampato a una caduta nel porticciolo.
«Il gatto!», urlò a sua volta.
La ragazza scoppiò a ridere, poi Angelo la sentì accovacciarsi e rialzarsi. Il miagolio irritato che ascoltò gli descrisse l’istante precedente in cui il gatto era saltato sulla banchina per rifugiarsi tra le braccia della ragazza. Angelo si affrettò a ringraziarla e a scusarsi, ma la ragazza lo interruppe prima che potesse fornire una spiegazione: «Non ti preoccupare. Okay, forse adesso Gatto ti odia un po’, ma… te ne farai una ragione» ridacchiò, poi si presentò come Giulia. «Vieni con me. Ti porto a vedere una cosa.»
Angelo non fece in tempo a chiedere dove, cosa, e neppure a dirle che in realtà lui voleva andare a sentire le sterpazzoline. Giulia gli afferrò la mano e Angelo si lasciò guidare dalla sua nuova verità.
«Com’è?»
«Che cosa?»
«Il mare.»
«Azzurrissimo.»
Ma era notte e c’era il buio. Angelo lo sapeva che a quell’ora il mare non poteva che essere nero. Anche Giulia lo prendeva in giro.
Di colpo si sentì più solo di com’era stato tutti quegli anni alla finestra di camera sua. Ma cosa si aspettava? Era sulla spiaggia di un’isola. Lui e Giulia vivevano entrambi su un’isola circondati dal mare infinito-nulla. Forse erano diventati anche loro un’isola? Magari lo erano sempre stati.
Isola. I-s-o-l-a. Aggiunse una t e una o. Il suo destino era quello? I-s-o-l-a-t-o, come il carcere di Santo Stefano, come Giulia nella sua omonima villa a strapiombo sul mare, come lui nella sua casa sul porticciolo dell’isola su cui era confinato e destinato a restare, i-s-o-l-a-t-o su i-s-o-l-a, per sempre.
Si rimise in piedi, lisciandosi i bermuda per scacciare via i granelli di sabbia.
«Dove vai?», chiese Giulia.
«Dove devo stare. A casa.»
«Perché? Non ti piace qui?»
«Sei una bugiarda.»
Angelo non la sentì rispondere, ma avvertì distintamente le dita di lei aggrapparsi al bordo dei bermuda. Gli chiedeva di restare anche se era bugiarda come sua madre.
«Non posso.»
«Ho detto qualcosa di sbagliato?»
«Il mare», chiese lui, ancora in piedi, «come fa a essere azzurrissimo se è notte?»
Giulia scoppiò a ridere. Angelo immaginò i suoi lineamenti distendersi di nuovo in quella risata e stavolta ne fu spaventato.
«La notte non esiste.»
Angelo si chiese che cosa volesse dire, ma non diede voce ai suoi pensieri. Preferì tornare a sedersi sulla sabbia accanto a lei, in attesa di un significato per quella frase che smentisse la logica delle cose per cui la notte non può non esistere, no?
«Ho sempre avuto paura della notte», confessò Giulia, «ma ho scoperto che se fingo che non esiste non può farmi del male, così tutto di notte assume i colori della luce. Anche il mare nero diventa azzurro, come il cielo di giorno.»
«Come fai a vivere in una bugia?»
«Non è una bugia. È una realtà. La mia realtà.»
«Tipo la tua isola?»
«Se vuoi chiamarla così, sì.»
Angelo ci rifletté su. Se lei aveva la sua isola, forse anche lui ne aveva una diversa da camera sua. Forse più che i-s-o-l-a-t-i su i-s-o-l-a erano un arcipelago di isole lontane ma vicine, diverse ma più simili di quanto sembrasse.
«E la mia isola qual è?»
«Non l’hai ancora trovata?»
«È così che funziona? Bisogna cercarla?»
«O magari ce l’hai già. Solo che non lo sai.»
Angelo le diede ragione e non disse nulla, ma le tese la mano. Giulia l’afferrò e anche se Angelo non poteva saperlo, la immaginò sorridere.
«Mi aiuteresti a trovarla, la mia isola?», ebbe infine il coraggio di chiederle.
Giulia si tirò su trascinando con sé anche lui. Angelo le sfiorò le labbra con le dita e per la prima volta la vide sorridere.
Biografia
Francesca Barracca nasce in provincia di Caserta il 5 agosto 1997. Laureata in Filologia Classica, nel 2025 si diploma con un Master in Scrittura Creativa dell’Accademia Molly Bloom. Attualmente collabora con la testata online Classicult per la quale redige articoli di letteratura e recensioni di libri. Parallelamente, gestisce un profilo bookstagram (@frabiblia) con cui coltiva la sua passione per la lettura. Alcuni suoi racconti sono stati pubblicati su Scomoda, Narrandom e T.Tivillus.





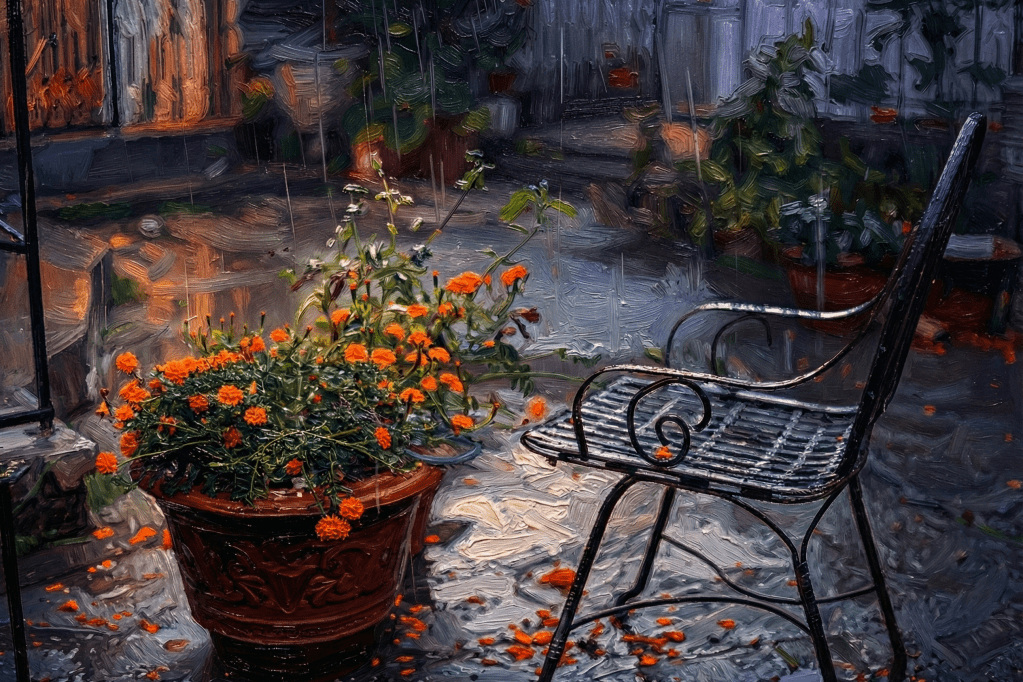
Lascia un commento